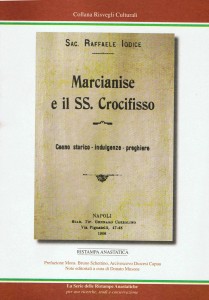Spesso ho desiderato di lasciare qualche segno della mia devozione verso il SS. Crocifisso, la cui immagine si venera nella collegiale e parrocchiale Chiesa di S. Michele Arcangelo di Marcianise; perchè, essendo a Dio piaciuto, che io fossi stato talora in gravi pericoli, ai piedi di quella Immagine ho avuto conforto al mio spirito, alimento alle mie speranze. Or nello scorso Aprile avvenne quella disastrosa eruzione del Vesuvio, (2) per cui una fiumana di gente si riversava in Chiesa, fervorosamente pregava ai piedi del Crocifisso, offriva doni, assisteva con edificante devozione al S. Sacrificio della Messa, per impetrare che nessun malanno incogliesse alle nostre campagne, alla nostra città. Questo m’ intenerì, e pensai che forse sarebbe riuscito utile e vantaggioso alla pietà dei fedeli, e a gloria di G. Crocifisso, scrivere dei cenni storici di quella prodigiosa Immagine.
Mi riuscirà, anche in minima parte, di conseguire il mio intento? Io non lo so; penso pertanto che G. Crocifisso, benignissimo sempre, si contenta del poco, e che, assai più giusto degli uomini, mi terrà conto dell’ amore che mi move a parlare, senza guardare alla imperfezione con cui lo faccio. I miei concittadini, ne son certo, faranno buon viso a questo scritto, perché l’amor mio verso la venerata immagine di G. Crocifisso è anche amor loro, e perché questo lavoro è anche una significazione del mio amore a tutti nel Signore. Marcianise, Luglio 1906. Sac.Raffaele Iodice
p. 5
Non molto lungi da Caserta e a una ventina di chilometri da Napoli, sorge Marcianise. Le opinioni intorno alla sua origine sono varie; e tutte hanno qualche parte di vero. Comunque nascesse questa nostra cittadina, e quasi certo che al tempo di Giulio Cesare, divenne una colonia considerevole, come sostengono con buone ragioni cronisti particolari. Questo casale era stato edificato attorno ad un tempio dedicato a Marte, donde secondo alcuni Martenisium, poi Martianisium, e finalmente Marcianise. L’essersi posti sotto la protezione del dio della guerra, mi fa credere al carattere bellicoso dei primi abitanti di questo ca-
p. 6
sale che, coll’andar del tempo passati sotto la protezione di un Arcangelo,rap- presentante del vero Dio nella lotta degli spiriti angelici, doveva camminare sulla via del progresso fino a divenire oggi una città, cui nulla manca di quanto faccia uopo a una vita civile. Situata in un tenimento dei più estesi e fertili della Campania felice, per la produzione della canape, il suo nome è conosciuto nei primi mercati d’Italia e d’Europa. Strade larghe; palazzi con ogni comodità; piazze ampie con bei monumenti; notevolissi me quello della Carità nella piazza omo nima, tutto in marmo, scolpito da quel decano dell’arte, nostro concittadino, Onofrio Buccini. Gli abitanti ascendono a circa 13 mila, la maggior parte dediti all’agricoltura, laboriosi, d’ingegno sveglio e di indole eminentemente generosa. Uomini illustri nelle lettere, nella medicina, nel giure, nelle arti ebbero i natali in essa; ma quello che forma, e giustamente, l’orgoglio di Marcianise è; la Congregazione di Carità, con una rendita annua di oltre lire 250mila, da erogarsi per opere pie, monumento solenne della munificenza degli avi, che trovararo riscontro nell’Italia intera; la Chiesa
p. 7
di Ave Gratia Plena, una delle più ampie e magnifiche. della Provincia, in cui si ammirano pitture dello Starace, del Narici, del Melanconico, del Marchese Solimena, e di Paolo de Maio, nostro concittadino; e la insigne collegiata e parrocchiale Chiesa di S. Michele Arcangelo, ricca anch’essa di pitture finissime dove si venera la immagine di quel Crocifisso, che per le grazie elargite a favore di Marcianisani, li ha resi un popolo prediletto. La prima è più bella grazia che Gesù ci abbia elargita , fu certamente l’aver voluto che la gran luce della fede avesse illuminate le menti dei nostri padri, vincendo ogni loro demerito, sin dai tempi apostolici. Invero, quando S.Pietro si recò a Roma condusse seco anche S.Prisco, cui elesse e consacrò vescovo di Capua, città ricca, possente, tutta dedita alla idolatria e ai piaceri. E facile immaginare di quanto zelo sia stato animato questo apostolo nell’annunziare la fede cristiana (1). San
(1) Capecelatro – Novena di S. Prisco.
p. 8
Prisco aveva dolcemente conversato, chi sa quante volte, con G. Cristo, e aveva udito proprio dal labbro divino di Lui le verità che costituiscono la nostra santa religione. Secondo una costante tradizione, il nostro divino Redentore lo amava tanto, che scelse la sui casa per celebrarvi l’ultima cena e istituirvi la santissima Eucaristia. In quella sacra notte che precedette il mistero della Croce, Gesù lo comunicò di sua mano insieme coi dodici apostoli; e questa fu grazia singolarissima che lui solo ebbe. Però senza badare a disagi e pericoli, S. Prisco venne alla volta di Capua, nel 44 circa, prese dimora fuori della città, nella via Appia; potè cosi predicare G. Cristo Crocifisso non solo agli abitatori della città, ma anche a quelli del contado. Ho io tutta ragione di credere che tra i molti e molti che subito si convertivano a Cristo, vi furono anche abitanti del casale di Marte. La ragione è questa: sulla via Atella, vicinissimo a questo casale, a quei tempi un di ogni settimana era mercato, cui affluiva gran folla dai luoghi vicini; sicché facilmente si poté propagare la notizia della venuta di un uomo, che an
p. 9
nunziava una nuova religione, che beneficava tatti dando la vista ai ciechi, la parola la parola ai mutoli, l’udito ai sordi e financo la vita ai morti. I nostri padri dovettero ascoltare la parola calda, persuasiva, efficace di quell’uomo: e se all’udirlo alcuni si infiammavano d’ira contro di lui, che s’adoperava a distruggere il culto degli dei falsi e bugiardi; altri si commovevano a pietà religiosa, e, vinti dalla grazia celeste chiedevano il battesimo e seguivano G.Cristo. Allora non potendo i nostri padri pregare pubblicamente, perché perseguitati dal paganesimo barcollante, si raccoglievano attorno a simboli, che raffiguravano fatti della passione di nostro Signore, in case particolari, abbellite quasi sempre da niun altro ornamento, che da fiori e lagrime. Ma spuntò alfine al giorno, in cuila Sposadi Cristo terse le lagrime per la cessata persecuzione, e indossò le vesti della sua allegrezza. Appena che i fedeli si poterono abbracciare liberamente tra loro e manifestare l’amore, che sentivano dentro, ecco trasformato e santificato tutto ciò che nell’ arte e nei simboli antichi, giudaici e pagani, era conciliabile con la vita della
p. 10
Chiesa. lì tempio di Marte fu convertito in tempio cristiano e dedicato a S. Martino: distrutto poi dai Vandali, fu riedificato nel1523 aspese pubbliche dove è attualmente. Il nuovo tempio fu consacrato a S. Michele Arcangelo, ed elevato a insigne collegiata e Chiesa parrocchiale da quel caro discepolo Gerolamo Savonarola, Nicola Scomberg (1), il quale per la molta e varia dottrina, e per servigi resi a più pontefici, fu insignito dall’arcivescovado di Capua, di cui fu il terzo Cardinale. In questo tempio, che è atre navi, e propriamente nella seconda cappella a sinistra di chi entra, si conserva la prodigiosa immagine del SS. Crocifisso.
Quando fu scolpita
Il culto cristiano è una parola misteriosa, che manifesta a Dio l’omaggio pieno di amore, che noi gli porgiamo. Or l’omaggio a Dio, specchiato nella parola
(1)Padre Marchese – Storia di S. Marco di Firenze.
p. 11
culto, si manifesta nella Chiesa per due modi principalissimi: l’arte e le feste. Premessa questa considerazione, si può benissimo affermare che Marcianise ha avuto per G. Crocifisso sempre una devozione e un culto speciale. Ben tre altari troviamo a Lui dedicati nella Chiesa parrocchiale; il primo sormontato da un quadro, che rappresenta la sua Agonia, sotto una cupola coi misteri della Passione dipinti; il secondo, detto una volta della Consolazione, (forse meglio Deposizione) oggi del Crocifisso; un terzo, detto delle Cinque Piaghe, dove attualmente sospeso il quadro della Consolazione. Da tempi remotissimi furono lasciate rendite per la celebrazione di messe quasi quotidiane ai suddetti altari, e messe solenni nei giorni dell’Esaltazione, dell’invenzione della Croce, nei Venerdì di Marzo col canto del Vexilla Regis – Ma questo non bastò alla fede de’ nostri avi: vollero che oltre al Sacrificio della messa, alla pittura, all’ architettura, anche la scultura rappresentasse e attestasse la
(1) Capecelatro. La dottrina cattolica, volume II. 434.
p. 12
loro fede in modo sensibile, e con le forme di una bellezza tutta pura e celeste fosse aiuto, conforto, difesa tra i dolori della vita, sorgente di luce, che rischiara il· cammino verso l’eterna città. E però nel maggio del 1706, alcuni del clero, sempre sollecito del bene delle anime, interpreti del desiderio del popolo di Marcianise si recarono a Napoli, per fare acquisto di una statua di Nostro Signore sulla Croce. In Napoli, dove oggi è il Seminario piccolo, esisteva a quel tempo il Conservatorio dei poveri di Gesù; in esso si educavano fanciulli, si insegnavano arti, mestieri e anche musica. Quivi si diressero quei buoni sacerdoti, attirati dalla fama, che godeva Nicola Colombo, scultore in legno assai celebre, che forse insegnava in quell’istituto. Nella Chiesa annessa videro un Cristo morto in Croce, scolpito dal suddetto autore e non risparmiando a spesa di sorta, lo comprarono. La statua fu benedetta, e con grande devozione, trasportata a Marcianise, ricevuta da tutto il clero e dal popolo in processione: l’altare nella Chiesa parrocchiale, dove fu collocata, venne detto delle Cinque Piaghe. Noi non ci dilunghiamo a dire i pregi di questa opera:
p. 13
diciamo solo che artisticamente naturale e divinamente bella. Il pregio più’ bello però di questa Immagine una virtù prodigiosa, che Iddio le ha concessa. Pertanto non creda alcuno che questa Immagine abbia in sé la potenza dispensatrice di grazie, od operatrice di miracoli: è Iddio sempre, che li opera, quando noi facciamo suppliche, ravvivate dalla nostra fede alla vista di quella sacra Effigie. La virtù propria di operar miracoli, nascosta sotto forme sensibili, esiste unicamente nella SS. Eucaristia per la. reale presenza di Gesù Cristo, Uomo Dio. Per la tela dipinta, fosse pure da Raffaello, per il marmo scolpite, fosse pure da Michelangelo, avviene quello stesso di una madre, che guardi, baci, stringa al seno, coprendo di lacrime e, dirò, veneri la immagine del figliuolo perduto: certamente nessuno pensò mai che tutto questo gran tumulto di pensieri e di affetti nascesse in lei dalla tela dipinta e non dal figlio perduto (1). Le immagini sacre destano in noi un senti-.
(1) Capecelatro.La Dottrina Cattolica, volume II. 204
p. 14
mento naturalissimo e affettuosissimo; ci fanno pensare all’originale, riescono efficaci a ridestare la nostra fede per ottener grazie, di che abbiamo prove indubbie nella immagine del nostro SS. Crocifisso. A Lui ricorse sempre con viva sede Marcianise, sia che il cielo, fatto di bronzo, negò una stilla delle sue benefiche piogge alle campagne inaridite, sia che per le abbondanti acque recò danno alle seminagioni; a Lui ricorse se crudo morbo a mille mietè le vite, a Lui se la terra tremò, o il formidabile, sterminatore Vesuvio seminò la desolazione morte e fè cadere densa pioggia di cenere; e sempre Gesù Crocifisso esaudì i Marcianisani, che alla sua immagine si abbracciavano e mandavano i sospiri e i voti più ardenti del loro cuore. Certo sarebbe nostro desiderio e insieme nostra grandissima consolazione mostrare in tutti i particolari lo spettacolo grandioso e commovente dei fedeli, prostrati ai piedi del Crocifisso nei giorni della sventura per impetrar grazie, e nell’ora in cui scioglievano il loro inno di ringraziamento, perché esauditi. Ci restringiamo ad esporre fatti più importanti. Come pure tralasciamo di ricordare
p. 15
inimicizie spente, la pace domestica ridata alle famiglie, guarigioni ottenute, e le numerose grazie spirituali, che sono le più belle e più desiderabili, e che G. Crocifisso ha concesse anche in gran numero. Faremo parola di alcune grazie temporali le quali riescono efficaci a vantaggio della nostra fede, come quelle che colpiscono maggiormente i nostri sensi, dai quali, chi più chi meno, ci facciamo guidare negli affetti del nostro cuore.
Il 1779
Come abbiamo accennato innanzi, Marcianise è una cittadina eminentemente agricola; è tale e stata sempre. Le sue campagne fertili e ubertose, quando il cielo le irrori di piogge fecondatrici, fanno concepire belle speranze ai contadini, che dal ricolto traggono ogni loro ricchezza. Il 1779 cominciò molto male per i campi; fin dall’ ottobre precedente non stilla di piogga era caduta, né cadde al cominciare del nuovo anno. Gran aveva durata il colono a rivol-
p. 16
tare il terreno indurito, e mesto aveva affidato ai solchi il tesoro del seme. Germogliò il grano, ma il suo stelo era sottilissimo, come quello del fieno, e le radici ( mi servo della espressione consacrata nelle memorie del tempo) erano fuori di terra, per mancanza di acqua e per li continovi venti. Lo sconforto regnava nei cuori; e quando tutte le speranze parevano perdute, (volgevano gli ultimi giorni d’aprile) i nostri padri si rivolsero a Gesù Crocifisso, che avevano in grande venerazione, ai suoi piedi fervorosamente pregarono, e formata una processione, clero, popolo di Marcianise e paesi vicini, portaronola Immagine benedetta per le vie della città. Il dì seguente si levò il sole, ma i suoi raggi non mandarono luce viva, come usa di primavera; l’orizzonte era coperto da una nube, che disciogliendosi in acqua ristoratrice, fè refluire la vita negli inariditi steli, la messe crebbe rigogliosa ed abbondante, talchè ogni moggio fruttò fino a 30 tomoli di grano. Prodigio veramente grande e inaudito da secoli! esclama lo scrittore del tempo. Pertanto vollero i fedeli mostrare la loro gratitudine per questa grazia sin-
p.17
golare ricevuta, e spontaneamente portarono offerte di grano alla Chiesa (circa 46 tomoli) subito dopo la raccolta, di guisa che ai 16 giugno fu fatta una festa in onore del Crocifisso, e col denaro che avanzò si stabili di costruirgli un altare di marmo. Ancora vollero che la festa, la quale usavano fare ai 14 settembre, giorno dedicato alla Esaltazione della Croce, si fosse fatta con maggior pompa, testimone e riflesso esteriore della loro fede. All’uopo fu delegato un Canonico, come si usa tuttora, per raccogliere le oblazioni, e custodire quella Croce, che, venerata fino allora, era divenuta per la recente grazia, un tesoro più preziosamente sacro. È questa la prima grazia di cui trovo fatta menzione; ad essa tien dietro una lunga serie di altre grazie, fino a quelle di cui noi stessi siamo stati testimoni.
Costruzione della Cappella
La immagine del Crocifisso era collocata dove ora è sospeso il quadro della Deposizione, sopra un altare detto delle
p. 18
Cinque Piaghe. Ma alla fede e alla carità dei Marcianisani non bastava que1l’altare quantunque fosse stato di marmo; vollero edificare una cappella, che meglio valesse ad esprimere la loro viva e cresciuta devozione per quella Immagine. Se non che costruirla dove era la statua non si poteva, perchè dietro l’altare una scalinata menava al sotterraneo sepolcrale. Si pensò quindi di erigerla dove era l’altare attiguo, trasportando al posto del Crocifisso il quadro della Deposizione. Per quanta diligenza io ponessi nell’esaminare ad uno ad uno i vecchi libri e le carte corrose, che si conservano nell’Archivio capitolare, non son potuto riuscire a determinare l’anno, in cui fu eretta la cappella; essa certamente anteriore al 1800 ed è la più antica nella Colleggiata. Non voglio tralasciare una pia tradizione sul modo come sorse l’idea della sua costruzione: é attendibile anche per il tempo non lungo che ci separa dal 1800 o poco giù di lì. Viveva a quei giorni una donna la quale, rimasta vedova in età non avanzata e non volendo saperne più del mondo si diede a una vita tutta devotamente cristiana. La sua condizione le permetteva di dedicare parecchie ore della gior-
p. 19
nata alla orazione nella Chiesa parrocchiale, dove si tratteneva particolarmente dinnanzi alla immagine del Crocifisso. Avvenne un dì che pregando genuflessa, coi gomiti poggiati sulla sedia e colla testa fra le mani (posizione che facilmente concilia il sonno) le parve di sentire Gesù che lagnavasi del modo niente decente, in cui si teneva la sua nicchia, ed esprimeva il desiderio che gli avessero Costriuta una cappella. Di questa visione, chiamiamola così, la buona vedova parlò al confessore, il quale per sola prudenza non perchè non le avesse prestato fede (era un’anima davvero timorata di Dio) le raccomandò di non pigliar più sonno in Chiesa. Ma questa visione si ripetè altre volte , di notte, nel sonno; e sempre la donna ne parlò al confessore, che ad insaputa di lei, osservò l’altare , la nicchia, e li trovò veramente non troppo decenti. Quando rivide la sua penitente le disse, che certo maggior decoro sarebbe stato costruire una cappellina. Non volle costei sentir altro: siccome aveva molti monili che sapevano di profano, se ne privò, dando quanto ricavò dalla vendita per la costruzione della cappella. La quale fu eretta e vi concorsero anche gli,
p. 20
altri fedeli col denaro supero della festa annuale . Ma, comunque sia sorta l’idea di costruire la cappella a noi giova far notare la devozione sempre crescente del popolo di Marcianise verso il Crocefisso, e le grazie che Iddio ha concesse a coloro, i quali ai piedi di quella Immagine le hanno implorate.
Il 1805
I geologi vogliono che la terra sia una volta liquida e incandescente: nel periodo attuale non ci sarebbe di solido che una crosta relativamente sottile, e sotto questa crosta una immensa fornace. Al fuoco centrale si attribuisce il terremoto, che in pochi istanti sconvolge intere regioni, i vulcani sarebbero sfiatatoi, onde parrebbe che le terre più vicine ad essi dovessero andar meno soggette a scotimenti. Eppure non é cosi: un terremoto sconvolse nel 1873 ed ha sconvolto di recentela Calabria, e non sono ancora muti gli echi del disastro di Casamicciola. Anche la nostra città fu scossa dal
p. 21
tremuoto; mai però in essa si ebbero a deplorare vittime, sempre per la protezione di G.Crocifisso. Mancava poco per la mezzanotte del 26 luglio del 1805, quando s’intese una forte scossa di tremuoto. Tutti balzarono di letto aspettando il giorno all’aperto, e trattenendo il respiro, come per non farsi scorgere da un nemico. All’alba un’altra scossa si ebbe, seguita da un rumore cupo, come di crollamento; rumore che favorito dal silenzio profondo, echeggiò per la città. Unanime fu l’invocazione del Crocifisso; il crollamento era avvenuto, la soffitta della nave che fa croce con quella di mezzo nella chiesa parrocchiale, e la cupola (1) che sovrasta all’altare maggiore erano precipitate pochi minuti prima che si fosse aperta la chiesa per la celebrazione della messa, cui interviene molta gente, che poi attende ai lavori domestici o campestri. Quando due anni dopo la soffitta e la cupola (1) furono ricostruite a spese del Capitolo, si celebrò una festa di ringraziamento all’Altissi-
(1) – Nel 1831 col concorso del municentissimo Card.Seraa,la Chiesafu ristaurata.
p. 22
mo; e l’oratore dell’occasione non mancò di ricordare la nostra sicurezza in ogni calamità, perché come antemurale conserviamo nel nmostro Tempio la prodigiosa immagine del SS.Crocifisso.
Il 1837
Quest’ anno segna per noi il più glorioso dei portenti; il 25 luglio e’ tramandato ai posteri, data memoranda della giustizia e della bontà di Dio; giorno solenne in cui con pubblica protesta si legarono più strettamente Marcianisani e il Crocifisso. O perchè importato da fuori, o per altra ragione a noi ignota, ai primi calori estivi si svilupparono semi di insolite mortalità; erano segni non dubbi di pestilenza. Il morbo poi, che toccò dapprima poche persone, sembrava ostinatamente ribelle ad ogni sorta di cura, sia perchè in brevissimo tempo spegneva le vite, sia perchè non note ne erano le cause, svariati gli effetti, innumerevoli i modi di appigliarsi e nuocere.
Non faceva distinzione tra giovani e
p. 23
vecchi, sani e malfermi in salute; uccideva tutti a un modo, con egual violenza, tra il secondo e il terzo giorno. Allora entrò tal spavento nell’ animo di tutti che, chiudendo l’orecchio alla voce della natura, dell’amicizia, della religione;l’uno fuggiva l’aspetto e il consorzio dell’altro e abbandonava nelle più grandi necessità le persone più care. Scena veramente orribile e straziante giacchè, quantunque in tempi di religione sentita e operosa; è raro in tali circostanze veder imitati i miracoli di carità, che fecero celebri e adorati in Milano i nomi dei due Borromeo. Era il mese di luglio: la gente periva, e vanivano meno le braccia al lavoro, quando questo è più necessario per le campagne: si temeva fortemente che la raccolta fosse andata perduta. Nè più felice era la sorte dei comuni vicini: solo il Cielo avrebbe potuto far cessare si grave sventura: e al Cielo si fè ricorso. Cominciarono pubbliche e private preghiere ai piedi di quel Crocifisso, cui non si era mai invano chiesto grazie; e il 25 luglio fu fatta una processione, della quale non si vide altra più numerosa e commovente. Fu portata quella benedetta Immagine per le
p. 24
vie della città, accompagnata dal popolo, anche dei paesi vicini, dal clero dalle autorità civili e militari: e come un giorno la Personadi Gesù passò per le vie di Gerusalemme facendo del bene e sonando tutti, cosi rinnovando il miracolo al passaggio del suo Simulacro per le vie di Marcianise sanò tutti, nè si ebbero a deplorare più vittime. La processione si fermò nella piazza principale del paese; l’Immagine fu collocata sulla soglia della Chiesa di S.Carlo , luogo elavato e a vista di tutti: fu redatto un pubblico istrumento, con cui il Municipio si obbligava di fare ogni anno ai 25 luglio una festa a proprie spese, di far pratiche col governo del Re e con l’ Autorità ecclesiastica, perchè quel giorno fosse stato dichiarato festa ufficiale, di precetto previo il digiuno . L’istrumento, letto tra un religioso silenzio, fu seguito da uno scoppio di alte grida, e lagrime di gratitudine e di gioia per la grazia, che evidentemente si era ricevuta, e a Gesù fu dato l’epiteto, che dura tuttora, di Crocifisso del colera. Le pratiche volute furono espletate tutte e presto, per quanto lo potevano permettere le comunicazioni non troppo facili allora trala Curia, la
p. 25S.Sede e Sua Maestà: fu dichiarato quel giorno festa ufficiale, di precetto, coll’obbligo del digiuno nel giorno antecedente, fu concesso di celebrare la messa votiva De passione, cui deve assistere il clero e tutto il Corpo comunale in forma ufficiale.
1884
Sul velo di seta cremisi, che si stende dinanzi alla immagine del Crocifisso, vedonsi, tra gli altri pregi, due Angeli che sostengono un nastro con questa dicitura: Marcianise liberata dal colera 1884. Questo solo basta a indicare quale grazia avessimo noi allora ricevuta. Quell’ anno il colera infieriva massimamente a Napoli, e chi non conta trent’anni, può riscontrare i giornali del tempo per farsi un’ idea della mortalità che affligeva la Cittàdell’incanto e paesi vicini. Noi si temeva che da un momento all’altro fosse stata colpita anche la nostra città, dove l’aria in està, benchè non cattiva, tuttavia non può ritenersi tra le più pure e salubri. Fu esposto Gesù Crocifisso alla pubblica venerazione: neppur uno morì
p.26
di colera, e in gratitudine di tale grazia furono celebrate messe e offerto quel velo di seta, che si vede tuttora. E dovremo ricordare ancora il 1894 quando per una siccità il seme, affidato da oltre una quindicina di giorni alla terra non era paranco sbocciato e appena si aprì la nicchia dove si conserva il Crocifisso, scoppiò un tuono fortissimo, che fu seguito da dirotta, fecondatrice pioggia? Dovremo ricordare il 1899, quando per le continue piogge i seminati erano stati assalita da tale abbondanza di vermi che ne impedivano il rigoglioso sviluppo, e appena fu calata dalla nicchia l’immagine del Crocifisso, fece bel tempo e la campagna crebbe come suoi dirsi, a ora? Tralasciando tutto questo, ci fermeremo al recente segno di predilezione, datoci da Gesù Crocifisso.
Il 1906
Quando siamo Colpiti da un male improvviso, spontanea: sorge sul nostro labbro I’ invocazione di Maria: prova eloquente del nostro amore versola Madre
p. 27
celeste, nella quale, perché donna, siamo usi a riconoscere, direi quasi, maggior tenerezza e premura a nostro riguardo. I Marcianisani, che nei sentimenti del cuore sono molto teneri, invocano sempre Maria nei loro bisogni, nelle loro particolari afflizioni. Basti osservare semplicemente il fatto che non vi è persona che emigri nelle Americhe, spintavi dalla cresciuta sete di denaro o dalla speranza di trovare, lontano dalla patria, il pane che forse neanche a stento gli concede il suolo natio, non v’è persona, dico, che non porti al collo l’abitino della Madonna del Carmine, o la medaglina della Vergine di Pompei, e in tasca il Rosario. Se non che, ove si tratti di pubblica sventura, come se si dimenticasse, per cosi dire,la Verginebenedetta, sotto qualsiasi titolo venerata, e si sentisse bisogno di in aiuto maggiore, tutta Marcianise e i paesi vicini corrono ai piedi del Crocifisso. Tratteggiare il quadro luttuoso della recente disastrosa eruzione del vesuvio sarebbe opera vana e superflua, quando l’eco dolorosa ci risuona ancora all’orecchio, e il vasto teatro della incommensurabile sventura è tuttora terrificante.
p. 28
e durerà per altri anni ancora. Riandremo brevemente quanto avvenne nella nostra città. Fin dai primi di aprile un panico indicibile aveva invaso tutti alla vista del grosso pino che si innalzava terribilmente maestoso sul cratere del Vesuvio. Grazie al Cielo, un leggiero venticello sospingeva cenere e lapillo al mare. Il giorno 12 però, il vento cambiò direzione e sul nostro capo si distese una densa, nericcia nube, che il dì seguente cadde in pioggia minutissima di polvere friabile, rossastra. Il Signore volle che la non fosse a lungo durata e al Sabato Santo, 14 aprile, propriamente quando nella Collegiata cominciò il canto sublime dell’Exultet, un venterello tolse dinanzi al sole quella nube, e la luce vicificante, l’alleluia cantato dai sacerdoti, il suono della campana, che annunziavala Risurrezione parvero ritornare la speranza nel cuore di tutti, specie dei Contadini, seriamente impensieriti per i seminati. Breve speranza! Eravamo ai 18 di aprile; il cielo da due giorni era divenuto di color fosco: la cenere lenta, sottilissima cadeva; il respiro pareva soffocato, a cento metri non si distingueva cosa alcuna. I gior
p.29
nali annunziavano che in città non noi molto lontane da noi era buio pesto, il transito impedito, le campagne sotto uno strato di cenere alto dove più, dove meno di mezzo metro; i seminati tutti andati perduti: alcune tettoie sprofondate sotto il peso di cumili di lapilli. E la cenere cadeva incessante, essiccante e, quantunque nel nostro tenimento non avesse raggiunta l’altezza di due centimetri, pure dannosa per le campagne, perchè, uscita bruciante dall’ immensa fornace del Vesuvio, sottraeva alla terra l’umidità tanto necessaria al primo sviluppo di qualsiasi seme. La sera di detto giorno la pioggia di cenere crebbe di intensità; s’aggiunse un vento cosi forte che, spazzandola dai tetti e sollevandola dalle strade, faceva un turbinio spaventevole. Parevano sconvolti e cielo e terra; porte e finestre malferme furono sbattute, alcune atterrate; sinistri bagliori accesero l’aria per qualche istante, e il cozzo dei venti furiosi mandava un fischio cosi cupo, che sembrava il finimondo. Grida assordanti si levarono al Cielo; si fece per le vie gran folla, che si riversò nella Chiesa parrocchiale, aperta con violenza; tra le grida e le lagrime di tutti fu de
p.30.
posta dalla nicchia la immagine del Crocifisso e collocata sopra un trono improvvisato, intorno a cui ardevano ceri a centinaia. Si stenterebbe a crederlo, se non; fossimo stati testimoni oculari: cessò tutto all’istante, e quando si tornò a casa, quel cielo che poco prima minacciava lo sterminio, era abbellito da qualche stella, che qua e là luccicava. All’alba un’acqueruggiola scendeva benefica sui campi, e quella cenere che avrebbe certamente inaridito, soffocato il seme e costretto i coloni a seminare di nuovo, si convertì in ottimo concime. Ora i contadini non credono ai loro occhi, vedendo la canape, il grano crescere rigogliosi, indizio certo di buona raccolta; laddove in paesi confinanti, ci duole il dirlo, o s’è dovuto spargere novellamente il seme, o la vegetazione viene su a stento. Di tanto beneficio, che tutti ascriviamo alla potente protezione del SS. Crocifisso, vollero i fedeli dare in segno di gratitudine, senza aspettare il giorno della festa annuale dell’Esaltazione della Croce, che si celebra ai 14 settembre. Messe quotidiane furono celebrate colle loro elemosine per oltre un mese; furono donati tanti ceri che, quantunque sempre
p. 31
accesi e in gran numero , ne avanzano dopo cinque mesi. Molte offerte ci pervengono da paesi vicini, da Napoli e dalle lontane Americhe e mandano il loro obolo per concorrere alla festa che si farà in onore del Crocifisso; quanti insomma hanno agio di venire a Marcianise si recano prima di tutto in Chiesa a pregare ai piedi di quella Immagine, che ha fatto dei Marcinisani un popolo prediletto.
Il 22 maggio
Quando avvenivano questi fatti, noi raccoglievamo notizie per scrivere il presente opuscoletto. Mancava però una notizia necessarissima: la data dell’acquisto della Immagine e il nome dell’ Autore; per quante ricerche avessimo fatte, frugando nell’archvio capitolare, non erano giunti a capo di nulla. Non smettemmo la speranza: e da capo ad esaminare quelle carte vecchie e polverose. Il Signore volle premiare la nostra costanza: ai 15 Maggio trovammo, acclusa in altro foglio, la fede della benedizione della
p.32
Statua del SS.Crocifisso: Essa fu comprata a Napoli nel Conservatorio dei poveri di Gesù, benedetto dal Canonico Cuomo della Cattedrale di Napoli e portata a Marcianise ai 22 maggio 1706. Eravamo dunque lontani di otto giorni dal 2° centinario. La notizia si sparse in men che si dica: suscitò tale entuasiasmo che si preparò una festa pei 22, il cui dolce ricordo non si cancellerà mai dal cuore dei Marcianisani: e si costituì allora stesso un comitato di persone, le più rispettabili della città, presieduto dal Sindaco, che insieme con l’economo, Rev. Primicerio, preparono feste veramente secolari per il 14 settembre.
Cittadini carissimi,
Sono molte le opere belle e generose che hanno legati i nostri padri a noi discendenti e che ci rendono onorati tra le città sorelle; ma bella e prima di tutte le glorie lasciateci in retaggio è un sentimento fervido di religiosa pietà verso quella immagine adorata, che con nobile
p. 33
orgoglio, come primo dei nostri vanti additiamo ai vicini e lontani fratelli. E’ un tesoro senza prezzo e come tale gelosamente custodirlo. Figli non degeneri, uniti in ispirito ai nostri antenati che gloriosi ora si compiacciano della nostra fede, giuriamo gratitudine e fedeltà a quella Croce, in cui s’incentra quanto la nostra patria e le nostre famiglie hanno di più tenero e dolce, e la religione di più santo ed augusto. Quella Croce ci unisca tutti in un sol palpito e mostriamo a tutti che nel nostro Crocifisso alimentiamo le nostre speranze, ravviviamo quella fede che fece grandi i nostri padri, illustre la nostra patria, di cui sentiamo ancora gli alti, nobili destini.
Deo gratias.
Indulgenze S. Santità Gregorio XVI concesse Indulgenza Plenaria da lucrarsi dai primi sino ai secondi vespri del 25 luglio, previe le debite disposizioni. L’indulgenza è applicabile anche ai defunti. Ad tempus novembre 1838.
p. 34
S.Santità Pio IX concesse l’Indulgenza plenaria perpetua nelle festività della Invenzione, 3 maggio, e della esaltazione della Croce, 14 settembre.
Nel 1875 fu concessa l’Indulgenza di 100 giorni in ogni venerdì dell’anno e la plenaria nei venerdì di marzo, sempre previe le debite disposizioni. Ad tempus.
Nel 1855 fu donata al Capitolo una Reliquia un Reliquia del santo Legno della Croce.
^^^^^
Novena delle Sante Piaghe di G.Crocifisso
Deus in adiutorium ecc. Gloria Patri…
1.
Signor mio G. Cristo, io adorola Piagadel vostro piede sinistro.
Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto dolore e con tanta amore; compatisco la pena vostra e della vostra afflittisima Madre. E per i meriti di questa Santa Piaga, vi prego di concedermi il perdono dei peccati miei, dei quali con tutto il cuore mi pento sopra ogni male
p. 35
per essere state offese della vostra divina Bontà Maria addolorata pregate Gesù per me. Pater Ave Gloria.
Mio barbaro cuor —La morte spietata-Te desti al Signor-Squarciasti le venerdì- Al caro mio bene- che langue, che muor- Che spira per te.
2.
Signor mio G. Cristo, io adorola Piagadel vostro piede destro. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto dolore e con tanto amore. Compatisco la pena vostra e della vostra afflitta Madre. E per i meriti di questa S. Piaga, vi prego di darmi fortezza di non cadere nell’ avvenire in peccato mortale; ma di perseverare in grazai sinoalla morte. Maria addolorata pregate Gesù per me.
Pater Ave Gloria.
p. 36
Ahime che martir !–Quel sangue sdegnato–Mi sembra sì dir:–Di un labbro spergiuro Gli effetti non curo:-Non odo gli accenti- D’infido amator
p. 3.
Signor mio G. Cristo, io adorola Piagadella vostra mano sinistra. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto dolore e con tanto amore. Compatisco la pena vostra e della vostra afflitta Madre. E per i menti di questa S. Piaga vi prego di liberarmi dall’inferno, tante volte da me meritato, dove non potrei amarvi più.
Pater Ave Gloria.
Se fosti offensor – Ricopristi almeno – D’un sacro rossor. – Deh! piangi e sospira,- Contempla e rimira-La croce, le spine – Qual sangue versò
p. 37
4.
Signor mio G. Cristo, io adoro la piaga della vostra mano destra. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto dolore e con tanto amore. Compatisco la pena vostra e della vostra afflitta Madre. E per i meriti di questa S. Piaga vi prego di donarmi la gloria del Paradiso, dove vi amerò con tutte le mie forze. Maria addolorata pregate Gesù per me.
Pater Ave Gloria.
E’ vero Signor–Pietà però spera-Dolente il mio cor.-D’Amor non si accese- Per questo ei t’offese- Condonagli il torto- Mio amato Signor.
5.
Signor mio Gesù Cristo, io adorola Piagadel vostro costato. Vi ringrazio di averla per me sofferta senza dolore, ma con sommo amore. Compatisco la vostra afflitta Madre, che fu sola a sentirne tutta
p. 38
la pena. E per i meriti di questa S. Piaga Vi prego di concedermi il dono del vostro santo amore, acciocché io vi ami sempre in questa Vita, per venire poi nell’altra ad amarvi eternamente in Paradiso. Maria addolorata pregate Gesù per me.
Pater Ave Gloria.
Quel prodigo son- che al padre sen siede-Chiedendo perdon-Ah! duolo, peccai!- E ben tu lo sai-fui perfido ed empio;- Ma tale non sarò.
Vere languores nostros ipse tulit;- et dolores nostros ipse portavit.
Oremus
Deus in cuius passione, secundum Simeonis prophetiam, dulcissimam animam gloriosae Virginia et Ma tris Mariae do–
p.39
loris gladius pertransivit, concede propitious ut qui transitixionem eius et passionem venerando recolim, gloriosis meritis et precibus omnium sanctorum cruces fideliter astantium intercedentibus passionis tuae effectum felicem consegnamur. Qui vivi set regnas in specula saeculorum. Amen.